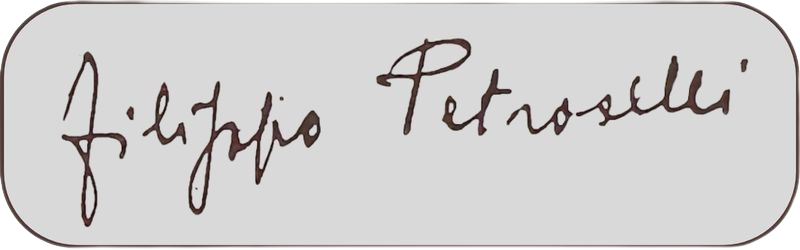Allegro ma non troppo: un titolo abusato e un libro – quasi – scomparso
Il volume di novelle Allegro ma non troppo è stato pubblicato nel 1949, per i tipi della casa editrice Gastaldi. L’ho letto al tempo delle scuole medie, ne ho riletto qualche pagina, di tanto in tanto, nel tempo. Recentemente ho ripreso a leggerlo, iniziando da una novella scelta a caso (che propongo di seguito) e decidendo che è arrivato il momento per una rilettura sistematica, dall’inizio alla fine.
Il titolo fa parte della storia ‘letteraria’ della famiglia: Allegro, ma non troppo, primo di due volumi contenenti ciascuno venti novelle (il secondo dei quali pubblicato nel 1953). L’autore è Filippo Petroselli (Viterbo 1886-1975), medico di professione e letterato, con molti titoli al suo attivo e giudizi lusinghieri da parte di critici e autori a lui contemporanei (Grazia Deledda, Bonaventura Tecchi, tra gli altri), e tuttavia rimasto ai margini rispetto alla variegata comunità di letterati.
Quella di Petroselli si può definire una storia letteraria ‘appartata’ e, oggi, sostanzialmente misconosciuta, che offre peraltro molto materiale sul quale riflettere. L’autore ha pubblicato e ha tenuto rapporti con critici, letterati ed editori, senza peraltro mai tralasciare la sua attività di medico e di specialista in malattie neuro-psichiatriche, accontentandosi per il resto di dare alle stampe i frutti della sua passione letteraria con case editrici diverse (Campitelli, Àncora, Gastaldi, Bemporad, ecc.)
Il titolo dei due volumi è un’espressione propria del lessico musicale, utilizzata in italiano – ovunque nel mondo – per indicare la velocità esecutiva di un brano. Una veloce ricerca online permette di trovare numerosi libri di vario genere (musica/poesia/narrativa) con lo stesso titolo, tutti recenti. Tra i tanti quello che vale la pena citare, è dello storico Carlo M. Cipolla (Allegro ma non troppo con Le leggi fondamentali della stupidità umana, il Mulino 1988, pubblicato originariamente in inglese) con il quale l’autore lascia la veste di storico per costruire due saggi ‘umoristici’, con l’intenzione di stigmatizzare in modo parodico le leggi dell’economia e parlare scherzosamente della stupidità umana. Per il resto appare un titolo un po’ banale e, dunque, decisamente abusato.
Il volume di novelle di Filippo Petroselli, al tempo della sua pubblicazione, non aveva rivali nel titolo, sicuramente appropriato rispetto ai contenuti: le novelle di ambientazione locale (vi si riconoscono paesaggi, usi, costumi della Tuscia viterbese senza peraltro che sia mai possibile per il lettore risalire a luoghi e personaggi specifici) sono generalmente brevi e colgono in presa diretta atteggiamenti, difetti, modi di fare di personaggi che rappresentano nel complesso una varia umanità con i suoi difetti ricorrenti, indipendentemente dalla condizione sociale.
L’attenzione per i particolari, pagina dopo pagina – le descrizioni naturalistiche, i tratti che delineano i personaggi, i primi piani sui luoghi di lavoro (botteghe, campi, uffici, ecc.), attività artigianali, professioni intellettuali o amministrative – è indice della perizia dell’autore nell’osservare con partecipazione – ora ironica, ora commossa o anche di aperta disapprovazione per vizi e soprusi, ora di bonaria comprensione per le piccole manie inoffensive – i fatti della vita, spesso espressione dello sguardo attento del medico nel quale emerge, di quando in quando, lo specialista in psichiatria.
Introduzione: ‘Tremenda vendetta‘
La novella che segue – Tremenda vendetta – si risolve in poco più di due pagine nelle quali l’autore narra il sopruso di un ragazzetto di famiglia agiata, annoiato, in cerca di uno svago purchessia e troppo sicuro di sé, che si accanisce contro un povero ‘ciabattino’ che si attarda a lavorare. Come ogni forma di narrativa, anche queste novelle sono espressione del proprio tempo: in questo siamo ancora nei tempi in cui un paio di scarpe veniva riparato più e più volte.
Per divertimento o per fastidio ‘politico’, il suo bersaglio diviene la carta rosso bandiera utilizzata dal ciabattino per chiudere la finestra in luogo del vetro, divenuto troppo costoso, divertendosi a sfondarla, quando, ogni sera, passa davanti alla bottega.



La soluzione trovata dal ciabattino per far cessare una volta per tutte il crudele divertimento del ragazzo ai suoi danni offre l’occasione all’autore per una citazione dotta dal XXVIII canto dell’Inferno (v. 26) ove Dante colloca quanti si sono macchiati di carneficine, gli uni contro gli altri armati, costellando la descrizione “con termini del linguaggio tecnico e del lessico quotidiano, di immagini minuziosamente schifose, con impudente maestria” (Dante, Inferno, commento di V. Sermonti, Bruno Mondadori 2000, p. 382).
La lingua utilizzata si caratterizza per l’uso di alcuni termini oggi desueti (zerbinotto, rovaio, gaglioffo, ecc.), per il ricorso accurato ma sempre accessibile al linguaggio figurato, per l’uso di notazioni coloristiche e uditive (‘rumoroso disastro’) e di caratteristiche fisiche (il naso ‘spartivento’), per suggerire atteggiamenti caratteriali in un crescendo che culmina nell’inaspettata situazione finale (‘aprosdoketon’).
La novella racchiude il succo della ‘poetica’ dell’autore e di tutto il suo modo di essere, caratterizzato da poche parole e lunghi silenzi (maturati già da medico militare durante la Prima guerra mondiale). Le une (le parole) e gli altri (i silenzi) dicevano molto a chi ne osservava l’apparente sdegnosa indifferenza e gli sguardi in cui si accendevano piccoli lampi ironici a svelare come il suo distacco fosse, in realtà, un modo per dissimulare l’acutezza e la partecipazione dolente con cui guardava al mondo e all’umanità.
Tremenda vendetta
Si era in quei beati tempi, beati almeno a confronto dei nostri che ci costringono a dirci nati sotto malignissima stella, nei quali non si sentiva così viva e pressante fame e sete di vetri.
Ma anche allora v'erano dei poveracci per i quali la rottura di un vetro significava un rumoroso disastro; disastro che li costringeva ad incollare nei riquadri delle finestre e delle porte in luogo dell'oggi purtroppo prezioso trasparente, un foglio di assai più economica carta.
A ciò era stato costretto anche Fluà, il ciabattino di via del Melangolo, che tanto era povero di denaro quanto ricco di figli.
L'una e l'altra di queste assai convincenti ragioni lo costringevano a vegliare, curvo sul negro e maleolente banchetto, fino a tarda ora, soprattutto d'inverno quando i giorni sono assai corti e le notti hanno il fiato di gelo.
A quel riquadro della porta aveva dunque applicato con la sua colla sempre inacidita, un pezzo di carta rossa tolta da un ampio manifesto residuo di vecchie lotte elettorali.
Ma il destino volle che quella carta od il colore di quella carta o l'una e l'altro dessero ai nervi ad uno spilungone di studente, malignuccio, magro, olivigno, con un assai notevole spartivento di naso.
Questi, la prima sera che passò di là – le strade erano deserte e spazzate dalla tramontana – fu colpito da quella novità e preso dall’irresistibile idea, non poté frenarsi di tradurla immediatamente in atto.
Con una ratta beccata della sua prominenza, lacerò il foglio ed introdotto il capo nel piccolo tempio del lavoro e della necessità, esclamò a voce crudele e faccia beffarda: “Ancora Lavori?!”
Poi, prestamente ritiratosi, sè ne fuggì a tacchi in aria prima che il poveraccio si fosse riavuto dalla sorpresa. Cosi accadde più volte: naturalmente una sera si e tre o quattro no lo studente a dar la sua ficcata con la solita ironica esclamazione appena dentro col capo, ed il povero Fluà ad incollare un altro pezzo del gran foglio rosso. Finito quello rosso fu costretto a metter mano a uno giallo, meno giallo però della bile di cui in quella mesata aveva fatto una non indifferente raccolta. Ma invano. Il suo, diciamo così, intellettuale nemico sembrò accanirsi ancor più contro il nuovo colore condannando con maggior gusto il povero ciabattino a quel sisifeo lavoro ed al gelido fiato della tramontana che quell'anno si ostinava a regnare in cielo e peggio in terra malgrado le imprecazioni e le sfrecciate degli intirizziti mortali.
Al terminar del foglio giallo, Fluà si trovò al punto di aver terminato anche tutta la riserva di pazienza e, quasi preso dalla disperazione, si vide costretto a ricorrere, come dicono i medici, ad un rimedio eroico il quale sortì l'effetto tanto desiderato dal poveraccio: di esser finalmente lasciato in pace al suo lavoro ed ai suoi pensieri.
Ed il nostro zerbinotto cadde nell'apprestato vischio. Quella sera di strada deserta e di ululante rovaio, diede con più gusto del solito la ficcata e con veemenza maggiore.
Ma l'indiscreta e crudele esclamazione fu sull'affiorare soffocata da una serrata repentina di labbra. Cosicché ne sortì invece un'altra, quella che i mortali anche più gaglioffi sogliono emettere dal profondo del cuore quando si trovano in penose ambasce: “Uh! Dio!”
E fuggì a perdifiato come se avesse visto in quell'ispido e canuto pover'uomo il diavolo in persona; fuggi scoppiettando starnuti, sudando freddo, assai più a precipizio che in tutte le altre precedenti imprese, facendosi alla meglio, a rispettosa distanza, schermo un po' con le mani alla faccia, ché con quella maschera di non profumato belletto fabbricato dal “triste sacco”, autentica Marca Fluà, troppo ignominioso sarebbe stato farsi vedere da altri mortali e tanto meno dai suoi.
E non frenò la corsa che dinanzi alla prima fontana ove, con fretta fervorosa ed assai gelida linfa si lavò, si stropicciò e ristropicciò con rude energia, faccia, orecchie e collo perfino.
Asciugandosi quindi alla meglio col fazzoletto, filò ad imbucarsi nell'entrata di casa. E mogio mogio sali le scale con nel naso, il maggiore colpevole, quel certo profumo Marca Fluà che non era proprio di gelsomino.